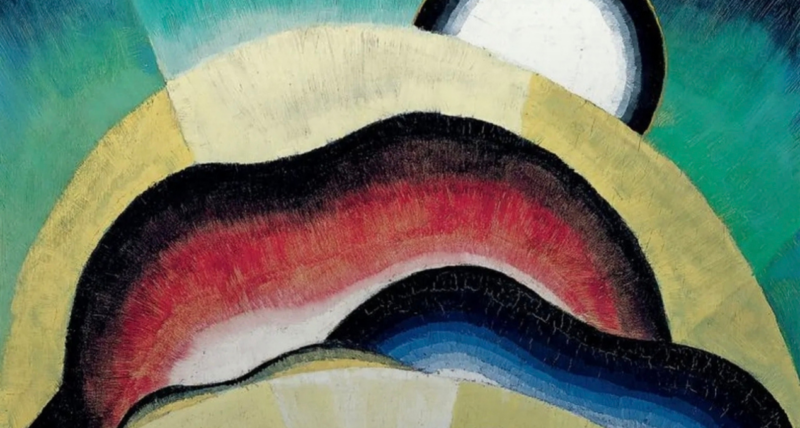Tra gli obiettivi dei laboratori della rassegna “Gennaio alla Liturgia” proposti alle Collaborazioni pastorali della nostra Diocesi c’è la riscoperta dell’Ordinamento Generale del Messale Romano. L’introduzione al grande libro per l’Eucaristia è un praticissimo manuale pronto all’uso, che parte dal riconoscimento della straordinaria importanza della Messa fino ad arrivare a prenderne in considerazione le declinazioni più minute, relative ai movimenti, al canto, alle varie ministerialità coinvolte, allo spazio, alle suppellettili. In appendice sono riportate alcune importanti precisazioni (a firma della Conferenza Episcopale Italiana), pensate per rispondere ai dubbi che possono sorgere rispetto ai gesti e agli atteggiamenti da tenere durante le celebrazioni.
La lettura di questa introduzione va suggerita a chiunque dia il suo contributo alla cura dell’Eucaristia, dai sacristi ai lettori, dai cantori agli artisti e artigiani che offrono i propri manufatti per arredare la chiesa, ai fedeli che desiderano diventare più consapevoli del significato e dei linguaggi del “Sacramento dei sacramenti”. Fondamentale strumento di studio, l’OGMR merita di essere la principale guida dei gruppi liturgici, che in esso troveranno una fonte sicura di ispirazione.
Il proemio esordisce con la spiegazione di come si è arrivati, dopo la riflessione del Concilio Vaticano II, alla composizione di un nuovo Messale. La forma del celebrare è mutata sulla base di esigenze che erano non semplicemente partecipative, ma ecclesiologiche, senza creare fratture nella tradizione, che viene definita “continua e ininterrotta, nonostante siano state introdotte alcune novità” [n. 1]. Il nuovo Messale viene presentato come il “compimento” dei desideri dei Padri conciliari riuniti a Trento, che non avevano mancato di raccomandare ai Pastori di rivolgere ai fedeli un’attenzione che li facilitasse nella “piena intelligenza del mistero celebrato” [n.12], lasciando intendere che poteva essere opportuno introdurre le lingue nazionali dove il latino risultava incomprensibile. La riforma concepita dal Concilio Vaticano II, aperto alle “cose nuove” evocate da Matteo (13,52), cerca di usare in ogni passaggio una soave prudenza, custodendo l’“armonia” tra il passato e il presente e mantenendosi pienamente rispettosa del “venerabile tesoro della tradizione” [n.15].
I capitoli dell’OGMR sono disposti in modo gerarchico, secondo una precisa struttura teologica, che sottolinea l’“importanza” dell’Eucaristia e la necessità che venga rivestita di una somma “dignità”. Non ci è chiesto di confezionare un abito sontuoso come quelli degli scribi, “che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle piazze” (Lc 20,46). Non è tale la logica del celebrare cristiano. Non ricerchiamo il fasto, ma la “nobile semplicità”, l’autorevolezza, la limpida essenzialità di quella tunica di Gesù cucita da cima a fondo, che nemmeno dei rozzi soldati romani stracciano.
Il Messale ci mette in guardia su quanto sia pericolosa la tendenza a ricercare la semplicità senza la nobiltà, la povertà senza la santità. Il primo fondamentale atto pastorale è allora lavorare per la dignità di una celebrazione, cominciando dall’aula liturgica, che va liberata dai troppi oggetti e decori che la colonizzano, memori di quel “Non fate della casa del Padre mio un mercato!” che Giovanni riporta nel suo Vangelo (2,16). Tutto è da pensare perché dia luce all’atto glorioso che è l’Eucaristia.
Presupposto fondamentale è evitare l’intromissione dei gusti personali. L’introduzione al Messale insiste a lungo su come la Liturgia abbia un proprio “senso autentico”, che andrebbe accolto senza cedere all’insofferenza per l’eventuale fatica che la sua corretta interpretazione richiede, dato che non si tratta di altro che di quel “giogo soave” di cui ci si deve sempre caricare per seguire il Signore e camminare sulla beata via della verità e della carità.
Conoscere l’architettura del rituale dell’Eucaristia è anche capirne la vocazione. Le sue singole “parti” vanno cucite insieme nel rispetto del loro senso proprio, in modo che possano infine realizzare quel prodigio che è l’evento celebrativo, dove l’insieme di una miriade di dettagli genera il simbolo del Salvatore presente in mezzo a noi.
Gianandrea Di Donna